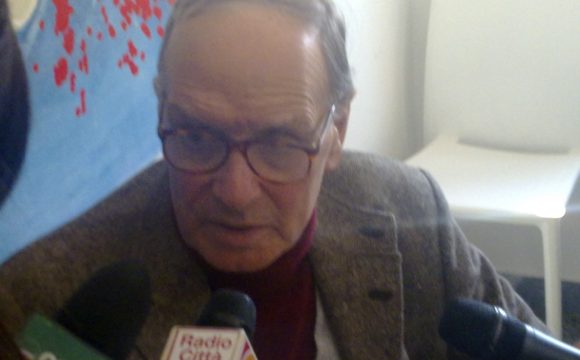[Fuori le Mura, 26 luglio 2010]
Lo scorso aprile le testate nazionali hanno portato a conoscenza dei lettori italiani il disagio che un numeroso gruppo di afgani vive a Roma, nel XI municipio vicino l’Air Terminal Ostiense. Mi promisi di andare a visitare quel campo, ma la distrazione della frenesia giornaliera mi fece dimenticare di quella piccola comunità. La scorsa settimana ritorna alla ribalta il problema, non tutte le testate ne parlano ma quelle poche che trattano l’argomento raccontano che questo gruppo di 150 persone è rimasto senza acqua da tre giorni a causa della chiusura dell’unica fonte idrica nelle vicinanze. Hanno avanzato una protesta al municipio di giurisdizione che ha sposato la loro causa e l’ha portata in Campidoglio. E’ stata promessa la sistemazione in tre centri di accoglienza e alcuni posti letto all’Ospedale Forlanini.
Ho pensato che in questo modo il lettore non avrebbe potuto ben comprendere la situazione reale di quel campo, che non avrebbe neanche potuto immaginare le storie e i volti di quella protesta. Così ho soddisfatto il mio desiderio, di alcuni mesi prima. Visitare quella comunità. Ci ho fatto un salto e ho rivolto alcune domande agli abitanti di quelle favelas.
[metaslider id=188]
Il campo è a ridosso di un cantiere edile. Su di un cancelletto in lamiera una scritta in pashto, “Grazie a Dio sono musulmano”. Quello stesso cancelletto in lamiera è l’ingresso del cantiere. Lì incontro un ragazzo, Shezad di 15 anni, con un termos famigliare da 5 litri. Gli chiedo di accompagnarmi all’interno e se qualcuno parlasse inglese. Attraverso il vialetto. Su entrambi i lati tende e strutture di copertura approssimative. Noto due silos di acqua. Shezad mi conduce in una baracca, con un piccolo ingresso, fatta con fasci di legno, di una grandezza di circa 3 metri quadri. All’interno sei uomini, seduti su coperte che mangiavano un pranzo a base di fagioli e qualche pezzo di carne, tutti intorno ad un unico piatto. Mi presento. Mi invitano a sedermi con loro e mi offrono un trancio di piadina inzuppata nei fagioli.
Più che un rispondere a domande, è un dialogo. Parlo soprattutto con Weis, un uomo sulla quarantina con un inglese sgrammaticato ma ugualmente chiaro. Mi dice che sono circa duecento in quel campo, provenienti da zone diverse dell’Afghanistan, con un’età che va dai diciotto ai quaranta. Ogni tanto si accavalla un ragazzo più giovane di lui, mi spiega che sono lì da tre anni, che non hanno mai avuto elettricità e che vivono senz’acqua da alcuni mesi. Weis mi spiega che in questi anni sono venuti diversi giornalisti ad intervistarli e a visitare il campo, anche con videocamere.
Weis mi dice che sono venuti un gruppo di italiani a portargli due silos di acqua, da 2000 litri e 1500 litri. Gli chiedo se appartenessero al comune o ad una organizzazione benefica ma non mi sanno rispondere. Il giovane ragazzo dice alcuni nomi, sono gli stessi che ho letto su di un quotidiano, dovrebbero far parte della onlus “L’albero della vita”.
La discussione si sposta al loro paese d’origine. Mi raccontano di un Afghanistan non libero, ma vivibile, con lo scoppio della guerra furono costretti a scappar via e dalla Grecia giungere in Italia. Gli chiedo se ci sono stati cambiamenti dopo la missione NATO e Weis mi risponde
“before bad live but life, now bad live and bad life”.
Weis inizia ad aprirsi e a parlarmi dei suoi sogni. Ricerca di una semplice vita degna e civile. Mi saluta in un modo particolare:
“Io ho due gambe. Tu hai due gambe. Io ho due braccia. Tu hai due braccia. I cuori sono di carne o di pietra. Il mio è di carne. Il tuo?…e quello dei governanti?” (ndt).
Un abbraccio e delle strette di mano, così abbandono il campo.
Il giorno seguente torno con due amici fotografi per creare un mini reportage. Il campo è semi vuoto. Mi viene incontro Shezad sorridente e salutandomi amichevolmente. Gli chiedo dove fosse Weis e mi risponde che è andato a riposare al fresco di un parco lì vicino. Mi offre del the e intanto alcuni dei ragazzi si fanno fotografare felicemente. Alcuni rifiutano, ma sempre con estrema gentilezza. Uno di questi, però, è ben disposto a chiacchierare. Parla bene italiano, mi congratulo con lui e mi dice che lui ha studiato per tre mesi in Germania, ma poi è dovuto tornare in Italia. Il perché mi fa ricordare di un aneddoto che il giorno prima quel giovane ragazzo mi aveva raccontato: quando arrivano in Italia, in questura o ai centri di accoglienza rilevano le impronte digitali, questo poi li costringerà a tornare in Italia quando vengono fermati negli altri Paesi dell’Unione Europea.
Prima di andare a Piramide mi dice, contento, che lunedì saranno trasferiti al Forlanini.
Abbandoniamo il campo. Ci fermiamo a fotografare la scritta “Grazie a Dio sono musulmano”. Sono contento per le conoscenze fatte. Per la forza di quei ragazzi. Con ironia però osservo quello immenso complesso residenziale in costruzione. Un enorme e noto cartellone pubblicitario sull’impalcatura raffigura un uomo a mezzo busto un po’ pelato che rende i nostri sogni solide realtà. Non so come faccia, però spero sia in grado di realizzare anche i sogni di Weis e compagni.